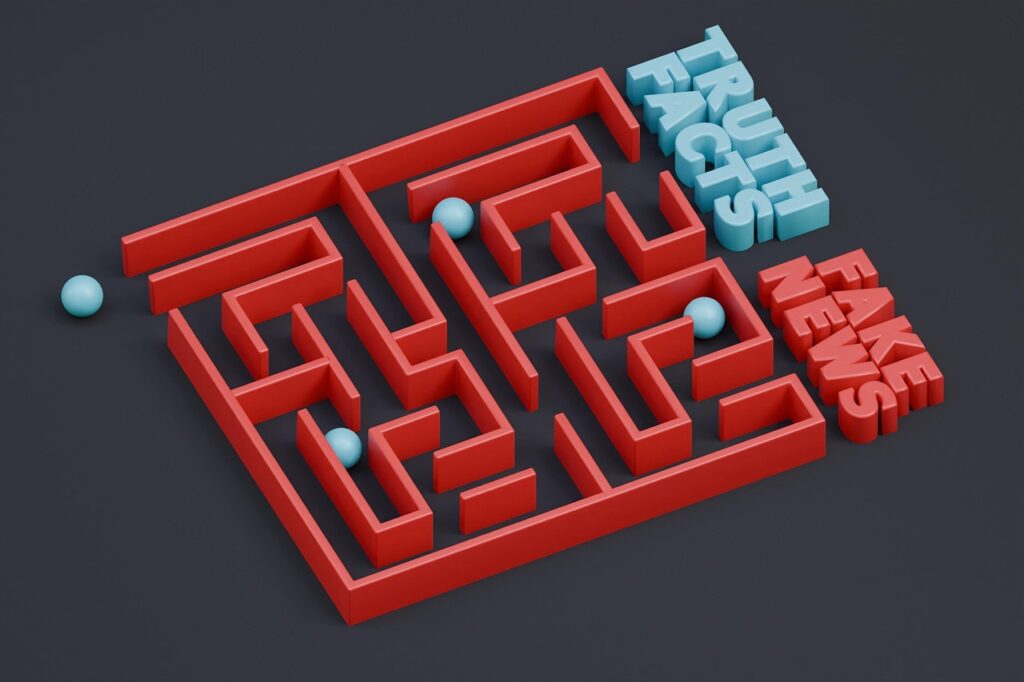Per anni abbiamo considerato la disinformazione una distorsione dell’ecosistema digitale, un errore da correggere o un eccesso da regolare. Ma adesso questa visione appare insufficiente. La disinformazione non è un’anomalia: è una strategia di potere.
Non nasce come effetto collaterale dei social network, bensì come dispositivo deliberato per governare attraverso emozioni, paura e appartenenza.
In questo scenario, la verità smette di essere il terreno del confronto pubblico e diventa un ostacolo alla costruzione del consenso. La politica, liberata dai vincoli della mediazione, utilizza la disintermediazione digitale per consolidare il proprio potere sull’annullamento del processo stesso di produzione della conoscenza. È un rovesciamento significativo: non si governa più informando, ma saturando l’attenzione.
Come ricorda il professor Michele Sorice, la sfera pubblica è uno spazio normativo e collettivo in cui cittadini, istituzioni e media co-costruiscono significato. Purtroppo questo spazio, già fragile, è attualmente eroso.
I partiti non rappresentano più corpi intermedi, i media tradizionali hanno perso la loro funzione di filtro e la discussione pubblica è stata sostituita da quella che possiamo definire una “politica sociale”: una forma di comunicazione che non punta alla deliberazione, ma all’attenzione.
I rischi che la disinformazione porta alla democrazia
La logica mediale, fondata sulla spettacolarizzazione e sulla semplificazione, ha preso il posto del dibattito. Come osservano i professori Nello Barile e Tito Vagni, l’immagine prevale sulla parola: non conta ciò che si dice, ma ciò che si mostra. La politica diventa un flusso di frame, emozioni e performance che saturano la percezione e svuotano di senso la discussione.
Il risultato è una democrazia ridotta a rituale episodico – il voto – priva però della sostanza deliberativa che dovrebbe sostenerla.
Il terreno ideale per questa trasformazione è quello dei social media. Le piattaforme digitali non sono infrastrutture neutre, ma architetture di influenza progettate per massimizzare il coinvolgimento, non la verità. Favoriscono ciò che genera reazioni rapide: contenuti emotivi, polarizzanti, semplici.
In questo contesto, l’individuo – che secondo il sociologo Manuel Castells avrebbe dovuto diventare agente di cambiamento – è ridotto a oggetto di consenso. Ottiene like, non relazioni; appartiene a una “tribù” digitale che conferma, invece di mettere in discussione.
E qui la disinformazione trova terreno fertile. Non ha bisogno di convincere, ma di risuonare. Grazie al confirmation bias (R. S. Nickerson, 1998), le persone condividono ciò che rafforza le proprie convinzioni. La falsità non è più un problema: ciò che conta è la coerenza identitaria del messaggio.
La propaganda novecentesca controllava i corpi e imponeva comportamenti. La guerra informativa contemporanea, invece, mira al controllo delle menti, agendo sulla sfera cognitiva ed emotiva. È quella che il filosofo sudcoreano Byung-Chul Han definirebbe “psicopolitica digitale”: un potere che non disciplina, ma seduce; non reprime, ma orienta.
L’autenticità è simulata – politici che mostrano la propria quotidianità per sembrare “veri” – e il rapporto con il cittadino diventa un filo diretto solo in apparenza. Dietro la retorica della trasparenza si muove una sofisticata macchina di manipolazione affettiva e algoritmica.
Oggi, la disinformazione non si limita a distorcere fatti: colonizza l’identità. Come ha scritto Francis Fukuyama, politologo statunitense, le rivendicazioni identitarie sono per definizione non negoziabili, perché riguardano ciò che percepiamo come immutabile – genere, etnia, appartenenza.
Il dibattito politico si sposta così dal piano delle politiche a quello del riconoscimento esistenziale. Non si discute più di cosa si vuole cambiare, ma di chi si è.
La rigenerazione culturale che spezza la bolla
Ogni gruppo si chiude nella propria bolla narrativa, alimentata da un flusso di contenuti che confermano il proprio punto di vista e demonizzano l’altro. È quella che potremmo chiamare una “secessione epistemica”: non esiste più un terreno comune di confronto, ma isole affettive con linguaggi e verità proprie.
L’unica via d’uscita è una nuova costruzione autonoma del significato: una rigenerazione culturale che restituisca alle persone la capacità di pensare insieme.
Significa tornare alla relazionalità reale, non solo all’interconnessione digitale. Significa riscoprire la lentezza del confronto, la capacità di ascoltare opinioni diverse, di restituire profondità a un discorso pubblico schiacciato dalla velocità. La tecnologia, in questo senso, non va demonizzata, ma riappropriata: come spazio da ricodificare in chiave dialogica, partecipativa, democratica.
Il nuovo ruolo del giornalista nel contesto attuale
Ma questa ricostruzione passa anche – e soprattutto – dal ruolo del giornalista. Nell’epoca della disinformazione strutturale, il giornalismo non può limitarsi a smentire le falsità: deve ricostruire contesti, offrire interpretazioni, riattivare fiducia. Il compito non è più soltanto quello di informare, ma di mediare il senso.
Il giornalista deve diventare architetto di comprensione, non semplice curatore di contenuti. Deve resistere alla logica del clic, recuperare la lentezza della verifica e della parola riflessiva, farsi ponte tra complessità e cittadinanza. In altre parole, deve tornare a essere un custode della verità, capace di mettere in relazione mondi e linguaggi differenti.
È in questa responsabilità – etica prima ancora che professionale – che il giornalismo può contribuire alla rinascita della sfera pubblica, restituendo al discorso democratico la sua profondità e la sua dignità.
La disinformazione è il sintomo visibile di una crisi democratica più profonda: quella di una società che ha smarrito i propri spazi di confronto, le proprie mediazioni e la propria etica del discorso.
Combatterla non significa soltanto smascherare le fake news, ma ricostruire i presupposti del sapere condiviso. Perché, indubbiamente, una democrazia resta viva solo se la consapevolezza illumina il giudizio e la paura non oscura la parola.
Image by Hartono Creative Studio from Pixabay