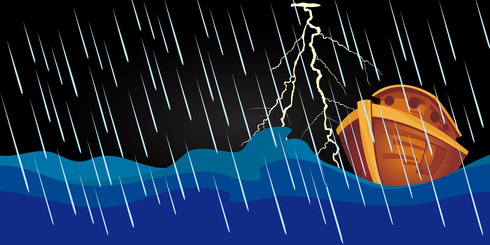Ci stiamo abituando a un giornalismo che “informa” ma che non “forma” coscienze libere e capaci di valutare l’accaduto. Le inchieste giornalistiche, considerate nel mondo anglosassone un vero e proprio “contropotere”, sono sempre meno utilizzate; l’eccessivo numero di notizie quotidiane, date una dopo l’altra, fa sì che esse assumano lo stesso peso, come, ad esempio, la notizia della vendita di un giocatore di calcio data subito dopo quella della morte di bambini in guerra; la notizia, una volta battuta dalle agenzie, è riprodotta da giornali, radio e telegiornali allo stesso modo per l’intero arco della giornata. L’ansia dell’arrivare per primi ha aumentato errori, imprecisioni e diminuito il controllo sull’attendibilità delle fonti; l’istantaneità dell’informazione limita la capacità di contestualizzare, ricordare, analizzare e confrontare le notizie tra loro; l’onnipresenza dei media sta abituando a far pensare vero ciò che emoziona, al punto che l’informazione, enfatizzando con il suo linguaggio il pathos (colpire le emozioni dell’ascoltatore), ignora il logos (educare a ragionare).
In definitiva, i tempi rapidi, la fretta nel selezionare tra le tante informazioni quotidiane le poche che diventano “notizia”, l’incapacità di trasformare in insegnamento il senso della notizia, ci può condurre a dubitare se l’informazione che ci viene data sia vera. Poniamo comunque che sia vera. Chiediamoci però perché manca di profondità? Perché oltre la morte non si riesce a dare vita?
È vero che chi parla all’intelligenza perde, mentre chi parla alle viscere vince? Sono le scene forti a colpire: un morto o un bambino che soffre. Altrimenti, che audience avremo? Ma immagini come quelle dei ribelli siriani ripresi mentre sparano in testa a dei militari catturati possono essere trasmesse con la leggerezza con cui sono finora circolate?
Alla fine di novembre 2014 ha impressionato il mondo una foto in primo piano, mandata via twitter, di un ragazzino palestinese colpito alla fronte. Non mancano poi cronisti che, in zone di guerra, registrano i rumori dei bombardamenti per farne il paesaggio sonoro dei loro servizi. A farne le spese è l’opinione pubblica.
L’informazione spettacolo narcotizza, incoraggia la passività e l’indifferenza, provoca fenomeni di abbassamento della scala dei valori di una società civile. Il pubblico assorbe le notizie come ipnotizzato da una fiction. Il singolo cittadino è costretto ad accettare la realtà e la fantasia, anzi a volte a credere che la fantasia sia realtà.
Su alcuni temi, come quello della morte violenta che entra nelle case attraverso i media, il giornalista credente non può che dire una parola diversa dalle altre. Vengono alla memoria le grandi catastrofi naturali, i corpi martoriati che commentiamo, i temi dell’eutanasia, insomma tutti quelli legati all’etica della vita. Non si tratta di dare altre notizie, ma di dare anche l’altra metà delle notizie che si fermano quasi solamente alla morte.
Un esempio di buona notizia è stata quella su Carlo Castagna, l’uomo che nella cosiddetta “strage di Erba” del 2006 ha perduto la moglie, la figlia e il nipote, e che ha pubblicamente e ripetutamente perdonato gli assassini dei suoi cari. Comunicare «la vita buona» è una delle sfide del giornalismo per ritrovare la sua più nobile missione, quella di dare voce a chi non l’ha, perché la credibilità si fondi sull’integrità, l’affidabilità e la coerenza del giornalista, che possono essere definite anche come un’alta forma di fedeltà alla democrazia. È “vita buona” la notizia che mette al centro la persona; sotto questo profilo Papa Francesco nell’Evangelii gaudium è lapidario: «Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa» (n. 53).
Parlare della morte per un giornalista sembra scontato. E invece non lo può essere mai. Perché le notizie che toccano la morte raccolgono un altro confine, quello tra la natura e la cultura. Tutti muoiono, però la natura e gli uomini la interpretano e nella natura produciamo cultura per umanizzare la morte stessa. La morte è natura e cultura insieme.
In ogni notizia la morte non esiste allo stato puro, la sperimentiamo solo interpretandola e vivendola con gli occhi puntati sulla vita. La morte è davvero l’ultimo male nelle notizie che diamo? A questa domanda siamo chiamati noi a rispondere. Della morte è stato scritto che è “il supremo atto di fiducia nella bontà del reale, nonostante lo scomparire dell’individualità”.
La religione poi rischia di complicare le cose. Manca un corpo al bilancio dei conti della morte, la somma non torna e l’evento più certo della vita è stato falsificato. È l’amore che vince e distrugge la morte. E se si raccontano i gesti del quotidiano amore questi umiliano la morte, costruiscono pace e giustizia e sconfiggono la sua strategia di distruzione.
In realtà anche nelle notizie che si danno chi è abitato dalla morte sono i malvagi. Quelli sono morti che camminano senza rendersi conto che la morte li hai conquistati e già vinti: chi uccide, gli usurai che distruggono famiglie, quelli che si arricchiscono sugli altri, chi non vuole ridistribuire le ricchezze, chi non si commuove quando i suoi vicini stanno male. Ma quelli che amano hanno già sconfitto la morte, contro loro non può nulla. È la forza della croce.
Il giornalismo aiuta a scolpire nel cuore che ogni ricordo è presenza! Non muore nessuno nel cuore. Lo vediamo dovunque, nelle nostre famiglie come nella storia profonda del mondo: chi ha avuto il cuore più limpido ha indicato la strada, chi ha molto pianto ha permesso di vedere più lontano, chi è stato più misericordioso ha aiutato tutti a ricominciare.
Anche la Chiesa canta durante le lodi mattutine del giorno dedicato alla memoria dei defunti:
“Mi hai formato dalla terra,
mi hai rivestito di carne:
Dio, mio redentore,
fammi risorgere nell’ultimo giorno”.
È questa la speranza che non deve mai mancare in ogni servizio fatto da giornalisti che credono.